Tanatoprassi: il teatro di Dino Buzzati (I)
Translation by Annamaria Martinolli
Il presente saggio è tratto dai Cahiers Buzzati N. 1, Éditions Robert Laffont, Paris 1977, pagg. 85-133. L’autore è Yves Panafieu. La traduzione è a cura di Annamaria Martinolli. Si ringraziano le Éditions Robert Laffont per l’autorizzazione alla traduzione.
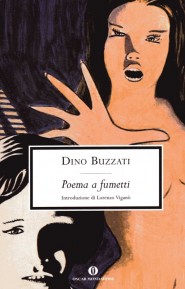 Con il termine Tanatoprassi si vuole qui alludere al valore catartico delle rappresentazioni e scenografie della morte nell’opera buzzatiana, dove all’ossessione motivata dall’angoscia si unisce sempre la preoccupazione di ammansire in anticipo quella con cui, presto o tardi, tutti i mali dell’uomo finiscono per estinguersi; a tale preoccupazione, già di per sé portatrice di un valore curativo, conviene aggiungere la volontà, espressa da Buzzati in alcuni passaggi della sua opera teatrale, di trasformare la morte in una sorta di antidoto atto a contrastare le potenze malefiche, affinché il Bene venga nuovamente accolto tra gli uomini.
Con il termine Tanatoprassi si vuole qui alludere al valore catartico delle rappresentazioni e scenografie della morte nell’opera buzzatiana, dove all’ossessione motivata dall’angoscia si unisce sempre la preoccupazione di ammansire in anticipo quella con cui, presto o tardi, tutti i mali dell’uomo finiscono per estinguersi; a tale preoccupazione, già di per sé portatrice di un valore curativo, conviene aggiungere la volontà, espressa da Buzzati in alcuni passaggi della sua opera teatrale, di trasformare la morte in una sorta di antidoto atto a contrastare le potenze malefiche, affinché il Bene venga nuovamente accolto tra gli uomini.
…In Poema a fumetti ho cercato di trasmettere l’idea che nell’aldilà la cosa più bella è la morte. La cosa che qui temiamo di più, laggiù è la più agognata. Laggiù l’uomo comprende che è proprio la morte a dare sapore alle cose della vita. In caso contrario, la vita sarebbe la cosa più spaventosa e stupida che ci sia. Quando l’uomo sogna l’immortalità, sogna la sua stessa infelicità, completa e stupida. Che senso avrebbe una corsa automobilistica se dietro non ci fosse il rischio della morte? Che senso avrebbe l’alpinismo? Che senso avrebbe l’esplorazione? Che senso avrebbe avuto andare al Polo Nord, senza il rischio di lasciarci la pelle? Sarebbe stata la cosa più stupida del mondo. Senza dubbio alcuno. Anche in amore l’idea della morte trova un suo fondamento. Nel suo significato più semplice, ovvero in quanto atto volto a mettere al mondo una creatura destinata a morire, sfocia anch’esso nella morte. (Mes déserts, intervista con Yves Panafieu, Éditions Robert Laffont, 1973, Paris, pag. 349)
“Hai paura della malattia?”
“Sì. La malattia mi fa paura”.
“Perché?”
“Perché la malattia è umiliazione”.
“E la morte?”
“Lo confesso: mi ha sempre fatto paura. Ma l’idea di morire – considerata con freddezza – ora mi spaventa meno di quanto facesse tempo fa. Questo perché ora credo di essere una persona un po’ più razionale. Adesso, mi spaventano di più la sofferenza e l’umiliazione”. (Mes déserts, pagg. 124-125)
È stato qualche insondabile decreto del destino a votare Dino Buzzati all’insuccesso teatrale, o possiamo affermare che egli stesso si è autocondannato senza saperlo? Eppure non sono stati né la mancanza di accanimento né la scarsa motivazione a condurlo ai fallimenti deplorati in questo settore durante le nostre ultime interviste. Il teatro esercitava su di lui un fascino molto forte, e la riprova è insita in alcuni frammenti di frase che si è lasciato sfuggire nel corso delle nostre conversazioni. E allora? Quale può essere la causa di un simile insuccesso? Da cosa può dipendere la fredda accoglienza che in genere il pubblico ha riservato alle sue opere? Buzzati, parlando della sua pièce Un caso clinico, ha forse trovato da solo la risposta alla domanda: “…Non c’è stato alcun successo. Non poteva essercene alcuno. E non potrà mai essercene uno. Questo perché si tratta di un testo che tocca lo spettatore e lo sconvolge”. Il nodo del problema, in effetti, potrebbe essere proprio questo prurito mentale al quale lo scrittore condanna lo spettatore, questa sorta di aggressione, attraverso lo sconvolgimento, che genera un dubbio esistenziale, con conseguente angoscia; dubbio esistenziale e angoscia che costituiscono poi il lotto della maggior parte dei testi teatrali composti tra il 1942 e il 1966. Il presente studio, realizzato a partire da nove dei quattordici testi che costituiscono il totale della produzione buzzatiana in questo ambito (Piccola passeggiata, 1942; Un caso clinico, 1953; Drammatica fine di un noto musicista, 1955; Il mantello, 1960; I suggeritori, 1960; L’uomo che andrà in America, 1962; La colonna infame, 1962; La fine del borghese, 1966; Le finestre, 1966), si pone l’obiettivo di aiutare a capire fino a che punto, anche nella sua ricerca teatrale, Buzzati sia rimasto aggrappato ai suoi fantasmi; più ancora di quanto non sia accaduto nei suoi racconti, romanzi o storie, dove il tono e i soggetti affrontati testimoniano, nel corso degli anni, un desiderio di diversificazione e rinnovamento, Buzzati è rimasto prigioniero, probabilmente per sua stessa volontà e condiscendenza, delle sue più grandi ossessioni, prima fra tutte la morte. Perché è proprio questo il ferro che l’autore, instancabilmente, ha cercato di battere, spinto da un’irreprensibile esigenza, che non si sa se definire come il semplice affioramento di un masochismo nel quale l’uomo si crogiola per una sorta di aberrazione dell’essere, e nel quale lo scrittore si sofferma perché in esso ha trovato la linfa della sua creazione, o se, al contrario, si tratta di una provocazione calcolata, grazie alla quale il moralista si sforza di brutalizzare il suo pubblico per instillargli il fermento dell’autocritica, e il germe delle ricostruzioni attraverso le quali ci si sforza di correggere il proprio carattere e di dare alla propria vita delle basi etiche e filosofiche diverse. Ad ogni modo, una cosa è certa: se le statistiche hanno valore di esempio, la ricorrenza tematica della morte, onnipresente nelle sue manifestazioni allegoriche o realiste in sette dei nove testi citati, dimostra un mutamento deliberato dei propositi buzzatiani e ci costringe ad esaminare con scrupolo tutti i significati di questa scenografia.
Fin dal primo testo, Buzzati annuncia la sua tendenza. Piccola passeggiata, atto unico rappresentato per la prima volta a Milano nel 1942, è un testo allegorico che disdegna volentieri le sottigliezze dell’illustrazione psicologica per tracciare il balletto della morte attorno alla figura dell’umile cavaliere Folletti. Questo balletto, di volta in volta pressante ed esitante, trae il suo procedimento narrativo dai fenomeni di incarnazione simbolica, spogliando in parte i personaggi della loro presenza carnale e della loro configurazione psichica per rivalorizzare, al contrario, i dati situazionali. In questa prima opera si manifesta – o piuttosto, si conferma (perché la prosa narrativa dei romanzi e dei racconti ci aveva già abituati a simili tecniche) – la volontà deliberata di utilizzare i personaggi a vantaggio del significante e del significato, e di ridurre all’essenziale la problematica della rappresentazione teatrale: nello specifico lo scontro tra l’uomo e la morte. In seguito, le circostanze cambieranno, e anche i caratteri, le situazioni personali o le epoche potranno risultare diversi, ma ritroveremo sempre questa disputa che, per Buzzati, si colloca al centro della vita e si verifica in ogni istante. Il cavaliere Folletti avrà un bel farsi sostituire da Giovanni Corte (di Un caso clinico), o da Claudio Delorna (di Drammatica fine di un noto musicista), ma la danza macabra sarà la stessa, anche se in Drammatica fine di un noto musicista si veste di tonalità meno implacabili e meno lugubri rispetto a Un caso clinico. I pochi personaggi chiave, che abbiamo appena citato, non tardano ad accogliere nella loro schiera di sconfitti il giovane soldato Giovanni (di Il mantello), tornato a casa per un ultimo saluto, e il pittore Remittenza (di L’uomo che andrà in America) stacanovista della gloria. Gli uni e gli altri saranno poi sommersi dalla fiumana sanguinante degli appestati milanesi e dal corteo dei sacrificati e dei puniti che proliferano ne La colonna infame. Come se l’annientamento con cui si conclude sempre, e in ogni luogo, questa prova di coraggio che è la lotta dell’uomo – consapevole della sua morte – e della Grande Falciatrice dovesse raggiungere una dimensione collettiva, riflesso di non si sa bene quale ecatombe terrestre. La colonna infame e La fine del borghese (che sotto l’allegoria individuale nasconde un’evidente volontà generalista applicabile a un’intera classe sociale, e che richiama anche le guerre del XX secolo), al di là del valore emblematico che hanno se prese individualmente, assumono un significato collettivo che bisogna riuscire a delineare, per poi meditarci su. Questo perché dietro a tale significato si profila, nascosta sotto la maschera dell’allegoria e del simbolo, una storicità che, in Buzzati, costituisce sempre un problema, a causa delle ambiguità e delle nebulosità che la caratterizzano.
Prima di soffermarci sui significati che Buzzati vuole privilegiare, e su quelli che possiamo noi stessi decifrare – sia che l’autore li abbia percepiti o no allo stesso modo – è opportuno analizzare nel dettaglio le ricorrenze di questa tematica principale.

 Tanatoprassi: il teatro di Dino Buzzati (II)
Tanatoprassi: il teatro di Dino Buzzati (II)