Le rovine e le ombre di Manderley: Rebecca dal libro al film (I)
Translation by Annamaria Martinolli
Il presente saggio breve è tratto da ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXVI 741 enero-febrero (2010) 43-52. L’autrice è María Donapetry dell’Università di Oxford. La traduzione è a cura di Annamaria Martinolli.
Ut pictura poiesis (Orazio)
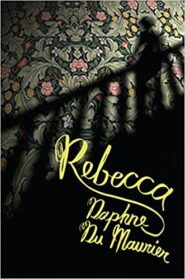 Nel manifesto critico del 1962 intitolato da Umberto Eco Opera aperta, in cui egli analizza nei dettagli la differenza tra opera letteraria e prodotto di consumo ripetibile ad nauseam, si asserisce con convinzione che un’opera letteraria considerata aperta non può avere un significato univoco e che di conseguenza nemmeno la sua interpretazione può essere tale. Parto da questa premessa (il testo letterario è sostanzialmente aperto) per poi entrare più nel merito del comportamento assunto dai cineasti le cui pellicole si basano su opere letterarie.
Nel manifesto critico del 1962 intitolato da Umberto Eco Opera aperta, in cui egli analizza nei dettagli la differenza tra opera letteraria e prodotto di consumo ripetibile ad nauseam, si asserisce con convinzione che un’opera letteraria considerata aperta non può avere un significato univoco e che di conseguenza nemmeno la sua interpretazione può essere tale. Parto da questa premessa (il testo letterario è sostanzialmente aperto) per poi entrare più nel merito del comportamento assunto dai cineasti le cui pellicole si basano su opere letterarie.
Molti critici hanno dimostrato di apprezzare il testo letterario più di qualsiasi pellicola ne sia stata tratta solo perché la pellicola o le pellicole non rispecchiano fedelmente il testo, come se questo “fedelmente” fosse tangibile e immutabile, soprattutto per quanto riguarda la lettura del testo e la sua conseguente interpretazione. Dal punto di vista cinematografico, questo avvicinare tramite “riproduzione” o “traduzione” un linguaggio (letterario) all’altro (filmico) si rivela sterile visto che la fedeltà che una pellicola può mantenere nei confronti del testo non garantisce assolutamente nulla. Il primo problema dell’idea di fedeltà al testo si esprime sottoforma di domanda: “Fedele a cosa?”; il secondo, altrettanto importante, è come fa una pellicola a essere fedele a un testo senza snaturarsi come pellicola.
È indubbio che l’intento di molte pellicole sia quello di farsi passare per versioni visive di un testo, ma è anche indubbio che nella maggior parte dei casi queste pellicole si rivelino flop colossali perché non riescono, non sanno o non vogliono capire che il rapporto tra testo e pellicola è soprattutto incentrato su concetti, immagini e interpretazione e non su parole e azioni concrete fissate in un testo che si cerca di trasferire in una pellicola.
Il segno verbale, di per sé, possiede un’iconicità molto bassa, eppure ha un’elevatissima funzione simbolica, mentre l’immagine cinematografica parte da un’iconicità ovvia (è un’immagine) e ha una funzione simbolica variabile. Se la persona che trae un film da un testo non tiene in considerazione le molte possibilità simboliche dello stesso, ovvero se chiude le sue possibilità connotative, finirà col trasformare la pellicola nella materializzazione visiva di un minimo comune denominatore. Viceversa, se inizia il suo lavoro tenendo conto e avendo consapevolezza dell’apertura del testo, la pellicola potrà esaminare non solo le diverse e innumerevoli possibilità connotative, ma qualsiasi di esse e suggerirne altre che ci inducano a rivedere il testo originale sotto un’altra luce. Parafrasando Christian Metz, il fatto che ogni produzione sia condannata a essere connotativa è la chiave della dinamica di scambio esistente tra due opere. Il testo di partenza dà vita a un sistema diverso di atti comunicativi che possono generare una risposta originale in un membro specifico del pubblico. In questo modo, la selezione di connotazioni dell’originale associata all’impatto emozionale che esse suscitano soggiace alla nuova produzione artistica che, a sua volta, farà emergere nuove connotazioni. I romanzi e le pellicole, secondo Kaemilla Elliott (Elliott, 2003, 1) sono arti sorelle che condividono tecniche formali, pubblico, valori, fonti, archetipi, strategie narrative e contesti. Quello che mi aspetto dallo studio di un testo letterario e di una pellicola che su di esso si basa è un rapporto reciproco: i significati devono essere interpretati in entrambe le direzioni tenendo debitamente in conto quello che le due arti condividono. Il discorso vale anche quando la pellicola defamiliarizza il testo letterario, ovvero: quando di primo acchito non riconosciamo il testo letterario e il film lo resuscita e lo rivitalizza (sempre che, ovviamente, indipendentemente dal testo si tratti di una buona pellicola), perché ci costringe a considerare possibilità interpretative che vanno oltre quelle risultanti da una prima lettura del testo ed evita di fornirci la comodità del riconoscimento istantaneo. Insisto nel sottolineare che la copia fedele di un testo, oltre a essere poco fattibile, è genericamente determinata da interessi economici, ma non estetici né etici. Questo modo di procedere sfrutta la fama e il prestigio dell’opera letteraria per trasformarla in un prodotto di consumo facile, veloce e comodo.
In questo contesto il mio compito non è solo quello di studiare la trasformazione di un testo verbale in “testo” filmico[1], bensì di esplorare anche alcuni rapporti reciproci di cui ho parlato che si instaurano tra un’opera e l’altra.
In generale, il cinema di Alfred Hitchcock non è affatto definibile come cinema letterario. Le sue pellicole funzionano in totale indipendenza rispetto ai testi su cui eventualmente si basano (e molte sono tratte da romanzi) non solo perché lo stesso Hitchcock si prende maggiori o minori libertà nel momento di scegliere o scartare passaggi di un determinato testo, personaggi o ambienti, ma anche perché fin dall’inizio concepisce la sua opera come una pellicola e non un adattamento. Hitchcock riesce a far sì che i suoi film rivestano un significato senza la necessità di ricorrere a un testo che li impronti in qualche modo per renderli intelligibili. “In principio era il Verbo” diventa per il noto regista “in principio era l’immagine”. Egli stesso affermava con insistenza di non leggere romanzi perché non lo interessavano. Queste affermazioni, tuttavia, vanno prese con un certo scetticismo in quanto altri lo hanno definito “un divoratore di libri”. Hitchcock conosceva di persona Daphne du Maurier, era informato sulla sua opera letteraria e, prima di recarsi negli Stati Uniti e iniziare la sua carriera hollywoodiana proprio con Rebecca, aveva già cercato di acquistare i diritti dell’opera in Inghilterra. Si creda o no nell’ingenuità delle sue affermazioni, è cosa risaputa che Hitchcock, come qualsiasi altro lettore o spettatore, interpretò selettivamente una storia e, partendo dalle “rovine della memoria”, la riformulò e ne produsse una sua personale.
Il regista francese François Truffaut sviluppò il concetto di “auteur” cinematografico e definì Hitchcock “l’auteur” per eccellenza. Le sue opinioni sull’attività cinematografica del regista britannico ci forniscono alcune chiavi interpretative degli interessi forse alla base delle motivazioni che l’hanno spinto a utilizzare diversi romanzi e racconti di Daphne du Maurier. In diversi scritti su Hitchcock, Truffaut insiste nel sottolineare che gli elementi comuni delle sue pellicole sono la paura, la soggettività onesta, lo scambio di personaggi, l’identificazione morale, e a volte quasi fisica, tra due esseri umani, i dilemmi morali, e, come evidenziato da André Bazin[2], lo squilibrio. Da par suo, la narrativa di Daphne du Maurier, e in particolare il romanzo Rebecca, anche se la critica lo ha costantemente definito “neogotico”, condivide con Hitchcock gli stessi elementi. Secondo Michel Serceau: “la tematica hitchcockiana è sempre una ricerca – decisa o improvvisata – per risolvere un enigma, compiuta da un personaggio sempre più minacciato dalla sua stessa ostinazione” (Serceau, 1989, 139)[3]. Non vi è dubbio che Hitchcock crei situazioni di suspense in cui le tensioni dei personaggi si proiettano sul pubblico, ma quello che di esse ci interessa, a parte il loro causare un piacere alquanto masochista e ansioso nel pubblico, è che in quest’ultimo attivano sentimenti che vanno oltre la semplice curiosità di scoprire cosa succederà dopo. In altre parole: chi assiste alla pellicola si sente coinvolto nei dilemmi morali dei personaggi, oltre a interessarsi alla risoluzione dei drammi. Daphne du Maurier si avvale sicuramente di elementi riconoscibili come appartenenti al romanzo “gotico”: la dimora isolata, tempeste e passioni, incendi devastatori, una “pazza” dell’attico, personaggi misteriosi e tenebrosi, personaggi femminili invalidi facilmente vittimizzabili o dominanti e imperscrutabili. Temo, tuttavia, che prendere in considerazione solo questi elementi significherebbe limitarsi agli aspetti formali del romanzo senza approfondire il modo in cui il lettore viene implicato nella storia e nella vita dei personaggi. Alla pari di Hitchcock, la du Maurier coinvolge il personaggio principale in una ricerca che la immerge sempre più in misteri da lei concepiti, in storie da lei stessa ideate, che la condizionano dal punto di vista fisico e psicologico e alle quali il lettore si sente in dovere di prendere parte.
Hitchcock parlò sempre di Rebecca sostenendo che non era una pellicola “hitchcockiana”. Esistono molti dettagli relativi ai retroscena della pellicola in grado di giustificare un’affermazione così insolita: David O’Selznick, il produttore, impose la sua visione dell’“adattamento” del romanzo e rifiutò a più riprese le modifiche proposte da Hitchcock; lo stesso Hitchcock si sottomise a questa dittatura perché si trattava della sua prima pellicola hollywoodiana; ecc… O’Selznick pretendeva “fedeltà” assoluta al testo con modifiche “minori” che convertissero la pellicola in una storia edificante per il grande pubblico abituato a Hollywood e al suo codice morale. Una di queste modifiche riguardò il fatto che Maxim, anziché uccidere Rebecca come avviene nel romanzo, si limita a essere testimone del colpo mortale che la stessa Rebecca si inferisce accidentalmente. Hitchcock fu obbligato a sottomettersi alle disposizioni degli Studios anche per quanto riguarda la scelta degli attori e delle star dello schermo. Tuttavia, credo che Rebecca sia indubbiamente una pellicola hitchcockiana, nonostante le ingerenze di O’Selznick e degli Studios hollywoodiani orientate alle modifiche endemiche. Ovviamente questi elementi erano fuori dal controllo di Hitchcock ma ce ne sono altri, “secondari” alla pellicola ma non al regista, che conferiscono a Rebecca una personale qualità hitchcockiana: la sua gesuitica ricerca dell’ordine, la necessità di confrontarsi con la paura che ogni britannico di quel periodo aveva provato durante la guerra e la consapevolezza che “l’alta” società inglese stesse agonizzando e che questo rappresentasse un passo avanti. Del resto, la stessa Daphne du Maurier apporta al testo o evoca nel romanzo alcuni degli elementi secondari che la contraddistinguono (non potrebbe essere altrimenti): un padre o una figura maschile imponente e dominante che bisogna placare, quello che resta di Jane Eyre nelle rovine della sua memoria o l’amore per le dimore signorili della sua natia Cornovaglia. L’importante è che questi elementi secondari – le opinioni di O’Selznick, le decisioni degli Studios, le idee ed esperienze personali di Hitchcock e quelle della du Maurier – aggiungano possibilità interpretative alla pellicola, al testo e al rapporto tra le due senza che una scelta interpretativa vada a scapito di molte altre.
Nel tentativo di organizzare il mio modo di approcciarmi alla pellicola di Hitchcock metterò in evidenza alcune differenze argomentative rispetto al romanzo omonimo. Potrebbero rilevarsene molte altre; alcune relative ai luoghi dove si svolge l’azione, altre riguardanti l’intervento di determinati personaggi, altre ancora connesse con l’eliminazione di personaggi che, per motivi suoi, Hitchcock considerò irrilevanti o non indispensabili alla trama. Le differenze a cui farò riferimento sono particolarmente indicative di quello che Hitchcock vuole raccontarci a partire dal romanzo della du Maurier e consentono una possibile lettura proprio della Rebecca letteraria. Quindi, ci focalizzeremo soprattutto su queste differenze e sul modo di rappresentarle, sulla visualizzazione filmica che trasforma il racconto “alla cieca” della[4] narratrice nel romanzo in un dramma tra “personaggi interni” e “personaggio esterno” che trova definitiva risoluzione nella distruzione totale di Manderley – il confine di separazione tra lei e gli altri personaggi[5].
Voce fuori campo, narrazione onirica e le rovine di Manderley
Sia il romanzo Rebecca di Daphne du Maurier che l’omonima pellicola di Alfred Hitchcock iniziano con la voce dell’anonima protagonista che ricorda il suo ritorno onirico a Manderley come introduzione a un racconto retrospettivo che costituirà la storia che ci sarà narrata: “Last night I dreamt I went to Manderley again. It seemed to me I stood by the irongate leading to the drive, and for a while I could not enter for the way was barred to me”. Hitchcock si avvale della voce fuori campo e visualizza il racconto onirico di questo Io facendo in modo che la cinepresa e la voce si identifichino e determinino un’uniformazione tra lo spettatore e Io. La scena è priva di raccordo[6] nel classico senso del termine (non vediamo Io che sogna o presente all’interno del sogno) e di conseguenza ci immerge completamente nella soggettività della voce incorporea senza riferimenti temporali o spaziali. “La notte scorsa” non significa nulla se non sappiamo di quale “oggi” o “adesso” si sta parlando. Questo presente relativo non apparirà mai nella pellicola, quindi il pubblico e la voce sembrano vivere nello stesso presente da cui parla Io. Il resto della storia, narrata in forma retrospettiva, è costituito nel libro dalla testimonianza di Io sulle sue esperienze e rapporti con Manderley e i suoi abitanti. Il testimone naturale narrativo del romanzo, come osserva Derrida riferendosi ai testimoni in generale, “sostituisce la percezione con la narrazione. Non può vedere, mostrare e parlare contemporaneamente…” (Derrida, 1990. Pag. 106)[7], mentre Hitchcock, fin dall’istante in cui la macchina da presa si identifica con la voce, ci coinvolge emotivamente nella storia e ci trasforma in testimoni oculari del suo evolversi con Io stessa come personaggio osservabile. In questo modo siamo resi partecipi delle tensioni psicologiche di Io non solo perché ci schieriamo dalla sua parte, come succede nel romanzo, ma perché Hitchcock ci trasforma in testimoni diretti delle sue tensioni. Io ci offre una visione parziale delle rovine della sua memoria. Il sogno di Io presuppone gli occhi chiusi, una cecità “visionaria” temporanea che cerca di spiegarci qualcosa fuori dal controllo cosciente del soggetto. La sequenza del sogno per noi mette in risalto proprio questa mancanza di significato specifico e suscita il desiderio di sapere, di svelare un mistero. Il sogno, per la protagonista, funge da riflessione sul passato, sulle rovine di Manderley e sulla vita da lei vissuta fino all’istante di raccontarcela. Nel romanzo, Io parla da un presente felice ed equilibrato raggiunto con grande sforzo e sofferenza. Hitchcock, come ho già avuto modo di sottolineare, non ci dà questa soddisfazione a priori. Non lo fa, secondo me, perché è costantemente focalizzato sulla tensione drammatica e su un’acquisizione di coscienza e di equilibrio parallela a quella dei personaggi della storia che la pellicola ci racconta.
Per tornare al discorso sulla voce fuori campo, l’effetto che genera sul pubblico è fargli vedere quello che Io non vede con i propri sensi ma con i ricordi emotivi. Quello che noi vediamo sono ombre oscure e minacciose destinate a permanere nella nostra memoria emotiva e visiva. Manderley appare fin dal principio come un fantasma del passato verso il quale, almeno la protagonista, non desidera tornare, eppure sappiamo di doverlo fare insieme a lei se vogliamo conoscere la storia. Questo gioco narrativo fortemente soggettivo coinvolge rispettivamente chi legge e chi guarda nella vicenda personale della protagonista. Come se non bastasse, ci informa che quanto stiamo per scoprire è sottomesso a un punto di vista unico: quello di Io dotata di voce ma priva di un corpo che ci guidi. Questo principio ci fornisce anche molte chiavi interpretative sugli elementi che serviranno sia a Daphne du Maurier che ad Alfred Hitchcock per proseguire nelle loro narrazioni: i desideri e i timori dell’anonima protagonista. Alcune delle chiavi interpretative riguardano il tempo e il luogo. Io è stata una persona estranea a un mondo, il mondo di Manderley, che l’ha attratta ma che allo stesso tempo la mantiene fuori in modo evidente. Le inferriate le permettono di vedere ma le ricordano di continuo la sua estraneità all’ambiente e il fatto che entrarvi richiederà non poco sforzo. In seguito, ci racconta che quando, nel sogno, riesce a entrare nella proprietà, la natura ha trasformato la strada e i giardini in un ambiente selvaggio e minaccioso, e quello che resta della dimora ricorda la grandiosità di Manderley, esempio di zenit di civiltà e di bellezza[8], ma ridotto a rovine illuminate fantasmagoricamente dalla luce della luna. Con ironia, nel corso del romanzo e del film, scopriremo che, per il personaggio centrale di Manderley, Maxim – la “persona all’interno” per antonomasia – Manderley è già contaminata e ha già perso il suo fascino perché, in definitiva, è la società reale che la abita ad aver sfruttato la sua superficie patinata per celare ogni tipo di nefandezza e decadenza morale. Maxim è sicuramente un “interno”, ma un “interno” che desidera con tutto se stesso uscire, anche se lo scopriamo solo ben oltre la metà della storia. Durante il resto del film, e fino alla confessione di Maxim, le ombre e le rovine di Manderley sono visibili in ogni scena come echi del principio onirico e segni premonitori del finale.
 A partire dal momento in cui Io appare a Montecarlo con l’odiosa Signora Van Hopper, dopo aver già conosciuto Maxim, i riferimenti a Manderley e, in particolare, a Rebecca generano in lei confusione e agitazione e prendono forma attraverso ombre che la avvolgono in modo discontinuo. Una delle sequenze più facili da ricordare è forse quella in cui Io, già sposata con Maxim, entra nello studio di Rebecca, che a Manderley si chiama “the morning room”, si siede allo scrittoio, osserva gli oggetti ivi collocati, nota l’agenda di Rebecca piena di titoli nobiliari sentendosi socialmente non all’altezza, sia dal lato psichico che fisico, e senza volere urta una statuina di porcellana facendola cadere a terra. La statuina è un prezioso cupido che, una volta ridotto in frantumi, Io si affretta a nascondere in uno dei cassetti dello scrittoio. La macchina da presa ci offre i primi piani del volto di Io quando le cade il cupido e delle sue mani che raccolgono i frammenti e li coprono con sollecitudine con alcuni fogli. In questa scena Hitchcock non lascia quasi spazio tra il volto di Io, le sue mani e noi in modo da renderci complici della goffaggine e dell’alienazione della protagonista. In seguito, quanto più si parlerà del cupido, della sua bellezza e del suo valore tanto peggio si sentirà Io e noi con lei; innanzitutto perché in poco tempo si scoprirà che è stata proprio Io a romperlo, e in secondo luogo perché non è un caso che si tratti proprio di un cupido e che sia appartenuto a Rebecca. Infatti, ogni volta che si parla di quest’ultima e della sua relazione con Maxim, l’aggettivo utilizzato è sempre “bellissima”, come tutte le cose di Manderley. Io ha rotto la statuita senza averne l’intenzione; o forse, senza averne piena coscienza, era davvero quello che desiderava fare. Anche se né Io né noi ne siamo consapevoli in quell’istante, sarà proprio il suo tipico atteggiamento da “esterna” a indurre Maxim a liberarsi dei suoi demoni. Il cupido, come l’amore di Rebecca, è vuoto e va in frantumi con un semplice movimento. Queste piccole “rovine” del cupido, a cui Hitchcock conferisce particolare enfasi, sono un’eco di quelle che abbiamo già visto nel sogno di apertura della pellicola.
A partire dal momento in cui Io appare a Montecarlo con l’odiosa Signora Van Hopper, dopo aver già conosciuto Maxim, i riferimenti a Manderley e, in particolare, a Rebecca generano in lei confusione e agitazione e prendono forma attraverso ombre che la avvolgono in modo discontinuo. Una delle sequenze più facili da ricordare è forse quella in cui Io, già sposata con Maxim, entra nello studio di Rebecca, che a Manderley si chiama “the morning room”, si siede allo scrittoio, osserva gli oggetti ivi collocati, nota l’agenda di Rebecca piena di titoli nobiliari sentendosi socialmente non all’altezza, sia dal lato psichico che fisico, e senza volere urta una statuina di porcellana facendola cadere a terra. La statuina è un prezioso cupido che, una volta ridotto in frantumi, Io si affretta a nascondere in uno dei cassetti dello scrittoio. La macchina da presa ci offre i primi piani del volto di Io quando le cade il cupido e delle sue mani che raccolgono i frammenti e li coprono con sollecitudine con alcuni fogli. In questa scena Hitchcock non lascia quasi spazio tra il volto di Io, le sue mani e noi in modo da renderci complici della goffaggine e dell’alienazione della protagonista. In seguito, quanto più si parlerà del cupido, della sua bellezza e del suo valore tanto peggio si sentirà Io e noi con lei; innanzitutto perché in poco tempo si scoprirà che è stata proprio Io a romperlo, e in secondo luogo perché non è un caso che si tratti proprio di un cupido e che sia appartenuto a Rebecca. Infatti, ogni volta che si parla di quest’ultima e della sua relazione con Maxim, l’aggettivo utilizzato è sempre “bellissima”, come tutte le cose di Manderley. Io ha rotto la statuita senza averne l’intenzione; o forse, senza averne piena coscienza, era davvero quello che desiderava fare. Anche se né Io né noi ne siamo consapevoli in quell’istante, sarà proprio il suo tipico atteggiamento da “esterna” a indurre Maxim a liberarsi dei suoi demoni. Il cupido, come l’amore di Rebecca, è vuoto e va in frantumi con un semplice movimento. Queste piccole “rovine” del cupido, a cui Hitchcock conferisce particolare enfasi, sono un’eco di quelle che abbiamo già visto nel sogno di apertura della pellicola.
Un altro passaggio tipicamente “hitchcockiano” del film è quando Maxim e Io stanno guardando il filmino del loro viaggio di nozze e il maggiordomo interrompe la visione per informarli che un altro domestico ha subito le ire della Signora Danvers essendo stato accusato da quest’ultima del furto del cupido. La scena è dominata da una narrazione strettamente filmica. Non solo i due personaggi stanno guardando una pellicola (il che riproduce la nostra condizione di spettatori) ma il montaggio delle scene ricavate dal filmino del viaggio di nozze e le sequenze di Maxim e Io a Manderley impegnati a guardare e discutere della loro “felicità” e a risolvere il problema del cupido per poi tornare a visionare la pellicola ci avvolgono in una tensione simile a quella provata dai protagonisti. La pellicola a cui assistono Maxim e Io mostra una coppia innamorata e felice, ben diversa da quella che vediamo discutere nel tentativo di nascondere l’allontanamento che si è prodotto tra di loro a Manderley. Non c’è un ponte visivo o emotivo che ci aiuti a creare un collegamento tra quanto da loro filmato e l’ambiente attuale. La pellicola di Hitchcock riesce a renderci partecipi dell’inconsapevolezza, del timore e della disperazione di Io. A questo montaggio, e “contenuto”, argomentativo va ad aggiungersi il gioco di luci e ombre della scena. Il fatto che l’illuminazione dei personaggi, Maxim e Io intenti a guardare il filmino, arrivi proprio dalla pellicola che stanno visionando per poi interrompersi a causa di un dramma domestico (che come abbiamo visto è molto più ricco di significato per Io), e poi il ritorno alla visione di un Maxim sorridente, che fa smorfie e abbraccia Io durante il viaggio di nozze – mentre il Maxim e la Io di Manderley sono immersi in un’oscurità fisica ed emotiva – ci riporta nuovamente all’incertezza ominosa del principio. Ancora una volta Manderley proietta le sue ombre sui personaggi.
Le rovine e le ombre di Manderley: Rebecca dal libro al film (II)
Note
Note:
[1] Confrontare linguaggio cinematografico e linguaggio letterario comporterebbe un lungo discorso che esula dalla tematica qui affrontata. La narrazione letteraria e quella filmica condividono molti aspetti che vale la pena studiare. Tuttavia, è importante essere consapevoli che si tratta di linguaggi di natura molto diversa.
[2] François Truffaut in The Films in my Life raccoglie una serie di recensioni su pellicole di registi che lui considera “auteurs”. Ovviamente, dedica diverse pagine a vari film di Hitchcock e cita anche l’opinione di André Bazin sulla qualità della suspense della sua opera (80). Un’altra importante opera di Truffaut incentrata sul regista inglese è Hitchcock, in cui raccoglie una serie di interviste con lui e, naturalmente, esprime le proprie opinioni.
[3] “Le récit hitchcokien est toujours une enquête –décidée ou impromptue– pour résoudre une énigme, menée par un personnage de plus en plus menacé par sa obstination même”.
[4] Poiché la protagonista/voce narrante non ha un nome, utilizzerò Io per riferirmi a lei come personaggio.
[5] In questo contesto, l’utilizzo di “interno” ed “esterno” corrisponde ai termini inglesi “insider” e “outsider”.
[6] Riguardo al termine “raccordo” nel cinema vedesi, tra gli altri, Jean-Pierre Oudart Cinema and Suture in The Symptom, online journal per Lacan.com https://www.lacan.com/symptom8_articles/oudart8.html, e il volume di Susan Hayward Cinema Studies. The Key Concepts.
[7] “substitue le récit à la perception. Il ne peut voir, montrer et parler en même temps…”.
[8] Manderley ricorda foneticamente la città di Mandalay in Myanmar (o Burma). Rebecca viene composta nel 1938 e all’epoca il Myanmar, amministrato fino al 1937 come parte del territorio indiano, era una delle colonie più importanti dell’Impero Britannico. Nel 1942, la colonia sarà occupata dai giapponesi.

 Le rovine e le ombre di Manderley: Rebecca dal libro al film (II)
Le rovine e le ombre di Manderley: Rebecca dal libro al film (II)